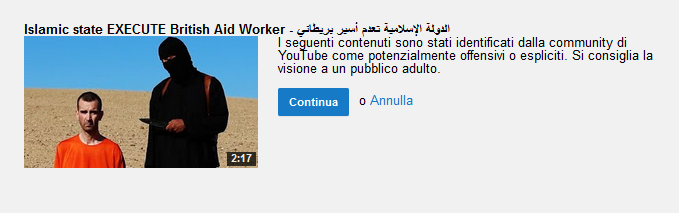Dopo la brutale esecuzione del britannico Haines si riaprirà la discussione, accesasi alcune settimane fa e che continua tutt’ora, circa la legittimità e l’efficacia della decisione di Twitter, e successivamente di Facebook, di non permettere la pubblicazione dei video delle decapitazioni dei giornalisti americani ad opera di IS. Decisione che è rimbalzata su tutti i siti d’informazione e testate giornalistiche è stata amplificata dai Social Network come l’annosa questione della libertà di espressione attraverso questi ultimi.
La polemica non è per niente nuova e da tempo i colossi del settore hanno adottato alcuni provvedimenti, più o meno intransigenti, che hanno animato la battaglia sulla libertà di parola.
Facebook nell’ottobre 2013 comunica di permettere la pubblicazione del video di una decapitazione (non ancora quella di Foley a Sotloff in Siria, ma di una donna probabilmente in Messico) e di conseguenza di ogni contenuto “violento” solo nella misura in cui non costituisca una “glorificazione” delle azioni che in esso sono mostrate. Uno dei portavoce del “libro” più cliccato in assoluto sostiene che gli utenti che condividono sulle loro pagine quel video unanimemente lo condannano e che la sua eliminazione tradirebbe lo spirito per cui il Social network si è sempre caratterizzato come uno spazio in cui le persone condividono le proprie esperienze, anche quelle relative ad eventi controversi tra i quali atti di terrorismo e di violenza in generale. Dopo alcuni mesi, pressato dalle critiche e dal peso dell’opinione pubblica, Facebook fa una vera e propria inversione ad U dichiarando che video di quel tipo verranno bannati fino a quando non saranno rivalutate le policy in materia.
Twitter nel gennaio 2014 sospende il profilo ufficiale di Hamas: le motivazioni risiedono nel fatto che l’organizzazione palestinese è considerata dall’Immigration Act USA una foreign terrorist organization e quindi non legittima ad utilizzare servizi, nello specifico Twitter, che soggiacciano alle leggi americane. Questa presa di pozione della compagnia di San Francisco ha immediatamente sollevato polemiche in merito alle evidenti ingerenze delle decisioni politiche in un ambito che dovrebbe essere scevro da ogni condizionamento se non quello imposto dalla comunità virtuale stessa.
Il video della decapitazione di Haines ieri è rimasto online per alcune ore in modalità liberamente accessibile su Youtube senza alcuna restrizione o indicazione circa la tipologia di contenuti che venivano mostrati. Sebbene la segnalazione circa i contenuti “potenzialmente offensivi o espliciti” del video sia stata successivamente aggiunta, le riprese della decapitazione dell’operatore umanitario britannico sono ancora visibili.
Questi sono solo tre esempi di quanto spinosa sia la definizione unica e univoca delle limitazioni alla pubblicazione di contenuti sui Social. Ad ogni modo una soluzione deve essere ricercata e trovata visto che ormai la guerra al terrorismo si combatte non solo “boots on the field” ma anche, e visti i recenti sviluppi di IS soprattutto, con “fingers on the button” cioè sfruttando le potenzialità dei Social.
Innanzitutto, è ovvio che diffondere un contenuto non significa necessariamente una sua condivisione “ontologica”: la maggior parte dei video-denuncia della violazione dei diritti umani provenienti da più parti del mondo vengono lanciati da attivisti o NGO sui i social perché contribuiscano ad innalzare la consapevolezza circa quanto accade, e non evidentemente nella maniera più categorica per validare tali azioni. Certo è che la responsabilità che deriva dalla pubblicazione di qualsiasi contenuto è da spartire tra chi lo produce e chi lo divulga: quest’ultimo è infatti egualmente complice degli effetti che il nuovo flusso di comunicazione da lui generato può sortire. A tale proposito la decisione inziale di Facebook di non permettere la pubblicazione di materiale audio/visivo che “glorifichi” la violenza, ma di accettarlo solo nella misura in cui la condanni, è assai lacunosa dato che l’immagine o il video in questione parlano di per sé e non sono unicamente un’aggiunta pleonastica ad un commento di denuncia o di esaltazione dell’atto che rappresentano.
Inoltre trova pochi consensi, specie per quanto concerne la campagna di comunicazione di IS, l’obiezione secondo cui qualora il “materiale pubblicitario” del califfo non trovasse posto su i maggiori Social sarebbe ugualmente diffuso sfruttando altri canali. La comunicazione del terrorismo si è evoluta esattamente nella direzione opposta ossia quella di portare la comunicazione del Jihad dagli strati “nascosti” della rete in superficie per raggiungere coloro che la popolano quotidianamente: la campagna di reclutamento avviata e portata avanti sui Social si fonda propriamente sulla familiarità dei riceventi con il mezzo 2.0 prescelto per lo scopo. È infatti proprio per la potenzialità virale di reclutamento che i Social sono di estremo supporto al terrorismo: ben prima di IS infatti la volontà del terrorismo di matrice islamica di impressionare l’occidente era affidata alla comunicazione mediata (il video dell’attacco alle torri gemelle, come quelli rilasciati da Bin Laden ne sono un esempio da manuale). Tuttavia i Social hanno aperto la strada ad una comunicazione meno main-stream e più user-driven capace di declinarsi in maniera più efficace in relazione a potenziali combattenti che possano ingrossare i ranghi dell’esercito dello Stato Islamico. La riprova della centralità di questi mezzi per la strategia del terrore e la loro necessità per il reclutamento è confermata dalle minacce rivolte ai dipendenti di Twitter mosse attraverso profili vicini ad IS che incitano i “lupi solitari” in America e Europa a privilegiarli come target delle loro azioni perchè corresponsabili della cancellazione degli account di IS e di organizzazioni affini.
E’ sicuramente difficile trovare una soluzione generale relativa a quanto il terrorismo sia legittimato a stare sui social specie se una definizione precisa di terrorismo non esiste in maniera ampiamente condivisa. Tuttavia, in questo particolare caso, un’alleanza strategica tra governi e compagnie private è probabilmente quello che serve: fatto del tutto ormai consueto e rodato, l’alleanza tra i due mondi è ampiamente sfruttata in caso di emergenze e si può dire, IS è un’emergenza. Impedire la propagazione virale dei contenuti prodotti dallo Stato Islamico non significherebbe quindi un atto di censura ma la dimostrazione di una responsabilità diffusa nell’adottare una strategia di prevenzione dei desiderata del terrorismo e dare così un duro colpo alla campagna di reclutamento di foreign fighter.